News
Intervista a Daniele Barbieri
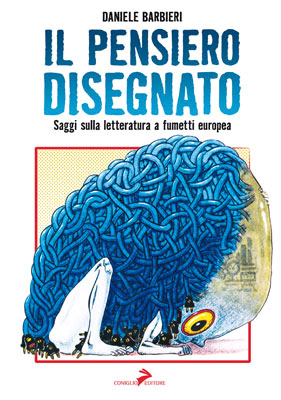
Daniele Barbieri, semiotico che si occupa di fumetto e di molte altre cose (danielebarbieri.it), ha da poco pubblicato per la Coniglio Editore Il pensiero disegnato, saggi sulla letteratura a fumetti europea. Il volume raccoglie vari saggi, scritti tra il 1983 e il 2007, legati tra loro da un fil rouge: capire quali siano le caratteristiche specifiche del fumetto e quali i suoi strumenti di fascinazione. Ci incontriamo per parlarne con l’autore alla Scuola Superiore di Studi Umanistici di Bologna, dove ha sede il Fondo Gregotti, di cui Barbieri è direttore. Dopo aver colto l’occasione per vedere alcuni splendidi disegni originali della collezione di Enrico Gregotti, possiamo iniziare l’intervista.
Partiamo dal titolo, Il pensiero disegnato. Mi ha ricordato il titolo del volume curato da Hamelin dedicato a Gianni de Luca, Il disegno pensiero, dove tra l’altro c’era proprio un suo saggio qui ripubblicato. C’è qualche legame con il suo titolo?
Il rapporto c’è sicuramente, anche se non è una dipendenza, perché Il pensiero disegnato era già pronto a quell’epoca e il titolo era già stato deciso. Però la coincidenza è significativa e ha assolutamente senso. Il fumetto è una forma di scrittura, e il modo di trascrivere le idee dà anche loro forma. Per fare un esempio banale, uno dei problemi che ci sono nelle traduzioni è che esprimere le idee in cinese non produce gli stessi effetti che esprimerle in una qualunque lingua europea, perché c’è una struttura linguistica estremamente diversa. Quando le idee si esprimono attraverso la narrazione a fumetti prendono forme che non possono prendere quando si scrive a parole, e naturalmente anche viceversa; e lo stesso discorso si potrebbe fare per il cinema. Come dire, non c’è nessuna traducibilità garantita, tra romanzo, fumetto e cinema, c’è una traducibilità approssimativa, si possono ottenere effetti simili, ci si può imitare a vicenda, ma un romanzo si esprime a modo suo, una storia a fumetti anche, un film pure, e alla fine sono tre prodotti diversi attraverso cui si possono esprimere sfumature di pensiero diverso. Quindi chiamare un libro Il pensiero disegnato in qualche modo vuol dire rivendicare una capacità critica intrinseca al linguaggio del fumetto e che è peculiarmente sua.
Infatti un’idea interessante, già espressa nel suo libro I linguaggi del fumetto e qui portata avanti, è che i linguaggi non siano solo strumenti ma anche ambienti, e che influenzino quindi il modo stesso di pensare un’idea. Ne Il pensiero disegnato lei individua lo specifico del linguaggio fumetto nel “battito-vignetta-evento”. Che cos’è? È comune a tutti i fumetti?
Certamente si trova in tutte le storie a fumetti, perché il fumetto è fatto di vignette e ogni vignetta rappresenta un evento; ogni evento è un “battito”, e la successione di questi battiti è ciò che caratterizza secondo me il fumetto. Poi però può assumere caratteristiche estremamente diverse: le vignette possono essere piccole, oppure pagine intere come quelle di Toppi, dove la vignetta coincide con la pagina ed è articolata al suo interno; possono raccontare eventi assolutamente minimali, penso ad esempio a Lone Wolf and Cub di Koike e Kojima, dove quando Ogami Ittō cammina ci sono quaranta inquadrature, e ciascun evento è un momento della camminata; oppure viceversa possono esserci macro-eventi come quelli dei drammi shakespeariani di De Luca, in cui l’evento è tutto il dialogo di Amleto con Ofelia. Tutti modi legittimi di raccontare, ma molto diversi, con un ritmo molto differente: da un lato una narrazione minimale, struggente, attenta al dettaglio, dall’altro un respiro epico e grandioso. Quello che hanno in comune queste cose così diverse è che il fatto di essere contenute in una vignetta le rende un’unità narrativa. E questa è una cosa che differenzia il fumetto dal cinema: il cinema può essere fluido, il fumetto no, perché non ha il movimento in sé ma lo deve creare attraverso una giustapposizione di momenti statici. Nel cinema possono esserci film giocati sui battiti, però ci sono anche film fatti con un unico piano sequenza, ad esempio il famoso Nodo alla gola di Hitchcock. Anche nel romanzo, le singole parole non sono battiti narrativi, e le frasi sono comunque collegate tra loro in modo potenzialmente più fluido. Per cui questa è una caratteristica secondo me piuttosto specifica del fumetto.
Nel suo libro parla anche del Poema a fumetti di Buzzati; perché secondo lei non rispetta le caratteristiche del fumetto?
Non è che non le rispetta. È un fumetto, però denuncia abbastanza apertamente il fatto di essere realizzato da un “dilettante”. Un dilettante geniale, grandissimo narratore; è una storia che io amo moltissimo, infatti ci torno periodicamente (recentemente in un post sul mio blog). Però si capisce bene che Buzzati non era un professionista: se lo confrontiamo coi fumetti di quegli anni è molto diverso da qualsiasi cosa che si veda. Lui era un appassionato di fumetti, e voleva costruirne uno a modo proprio. Buzzati era un discreto disegnatore e soprattutto era un uomo molto intelligente e capace di raccontare, per cui riesce a inventarsi un modo di fare fumetti che in quegli anni non c’era: in questo senso non è propriamente un fumettista. Infatti fu molto poco apprezzato dai lettori di fumetti, e capisco anche il perché: era fuori dal gioco, in un certo senso. Nei primi anni del Novecento, quando il fumetto era nato da poco tempo, ciascuno si inventava il proprio modo di farlo. Per cui ci sono episodi come quelli di McCay e Feininger che cominciano a fare cose per quegli anni assurde, diversissime, e una cosa del genere era normale. Sessant’anni dopo il fumetto ha già delle norme, e Buzzati si ritrova come a dover inventare il linguaggio del fumetto ex novo. Lui trova delle situazioni molto originali, che però hanno pochi precedenti.
Ho apprezzato in particolar modo, tra i vari autori da lei analizzati, il saggio su Dino Battaglia e sul suo uso del bianco: come forma, come sfondo del raccontato, come sfondo del raccontare, come tessitura. Ho provato anche a pensare se ci fossero degli “eredi” di Battaglia, ma non mi sono venuti in mente altri autori che abbiano portato avanti queste potenzialità.
Sì, credo sia vero. L’unico “battagliano” che mi venga in mente, però più per altri aspetti, è Corrado Roi. L’uso del bianco che fa Battaglia, per esempio nel modo di impaginare lasciando ampie aree bianche che potrebbero sembrare un eccessivo spreco di spazio, Roi in Dylan Dog non se lo può permettere, perché nasce in un contesto diverso. Magari Roi può, e lo fa, sfruttare altri usi del bianco: zigrinature, tampone, lo sfondo bianco invece che nero per esprimere l’oscurità (una scelta talvolta incredibilmente efficace). Tutto però deve rientrare nella cornice standard del fumetto bonelliano.
A proposito di Dylan Dog, lei scrive che continua a essere un lettore dell’investigatore dell’incubo, anche se un po’ annoiato. Ultimamente qualche episodio ha risvegliato il suo entusiasmo?
In questo momento non ricordo niente che mi abbia colpito in modo particolare, a parte un paio di episodi su cui era tornato Sclavi, ormai già tre o quattro anni fa. Non sto dicendo che non mi piace…
Dylan Dog quindi resta Sclavi?
Resta Sclavi, sì. Anche perché è un suo personaggio, e quando torna a lavorarci lui la differenza si vede, con tutte le qualità che possono avere altri sceneggiatori. Ci sono alcuni sceneggiatori della Bonelli che io apprezzo molto, come Ambrosini e il suo lavoro con Napoleone e Jan Dix, o Manfredi con Magico Vento. Non di rado trovo cose che mi colpiscono.
Alcuni autori ritornano in modo insistito nei suoi saggi: uno di questi è Lorenzo Mattotti. Cosa l’affascina particolarmente di questo autore?
Secondo me nei fumetti di Mattotti si esprime piuttosto bene quello che io intendo per “pensiero disegnato”. Mattotti riesce a utilizzare il disegno per esprimere delle emozioni, e riesce a farlo in maniera molto profonda, forse più di chiunque altro. Ci riesce anche nelle illustrazioni, basta pensare a un libro come Nell’acqua, che io trovo assolutamente struggente, dove non c’è nessuna storia, se non qualche frase che dà un senso di collegamento: chiaramente non è un fumetto, ma ciascuna di queste immagini è talmente intensa che si crea davvero un pensiero disegnato. Se questo pensiero venisse trascritto sarebbe un’altra cosa. E lo stesso accade nei fumetti di Mattotti; il che vuol dire che non solo ha una strepitosa capacità grafica, ma anche che a differenza di altri autori, che io apprezzo moltissimo come illustratori ma molto meno come fumettisti (come ad esempio Dave McKean), è capace di costruire il ritmo; sa quindi tenersi a freno sulla ricchezza del disegno per ottenere effetti sulla costruzione ritmica e narrativo-emotiva. Questo non è poco, anzi credo sia quanto di più si possa chiedere a un raccontare a fumetti.
Qualche tempo fa è apparso su Exibart.com un articolo di Gianluca Testa sulla critica di fumetti italiana, a cui ha fatto seguito un dibattito online sul blog di Matteo Stefanelli in cui anche lei è intervenuto. Uno dei nodi della discussione: il critico di fumetti deve avere una formazione specifica oppure è auspicabile una contaminazione tra i campi? Lei, che non si occupa soltanto di fumetti…
Io sono contaminatissimo…
Ecco appunto, qual è la sua idea al riguardo?
Secondo me c’è un’ambiguità nel termine “critico”, non solo nel fumetto, in generale. Prendiamo il campo del cinema, in cui esiste davvero una critica. Per “critico” intendiamo quello che fa le recensioni sui giornali o che so, Christian Metz, che magari non ha mai scritto una recensione ma è un grande teorico del cinema? In un certo senso sono critici entrambi, però hanno ruoli molto diversi: da una parte c’è quella che viene chiamata critica militante, che fornisce dei suggerimenti di lettura, delle chiavi interpretative di rapido consumo; dall’altra c’è il critico ricercatore, che individua nel cinema delle costanti più generali, ne analizza gli strumenti, traccia anche una storia. Trasportiamo questo discorso all’interno del piccolo mondo del fumetto (davvero molto piccolo, per quanto riguarda la critica): anche qui dovremmo distinguere questi due ruoli e non appiattire il critico del fumetto soltanto in quello della critica militante e giornalistica. Il critico dev’essere certamente specializzato, altrimenti non può parlare del fenomeno di cui si occupa; però io credo che il fumetto non viva da solo. Non si capirebbe nulla, tanto per fare un esempio, di Tiziano Sclavi, se non si avesse una certa competenza cinematografica e letteraria; non si capisce niente di Mattotti se non si conosce la pittura della prima metà del Novecento. Il critico di fumetti non può vivere in una bolla di vetro.
Leggo sul suo blog: “L’espressione graphic novel è entrata nell’italiano attraverso il suo uso al femminile: la graphic novel. Ci sarà anche un errore alla base di questo uso, ma è l’uso che fa la regola, e non viceversa”. Sono d’accordo, ma personalmente è l’utilizzo dello stesso termine “graphic novel” a lasciarmi perplesso: cosa indica, un genere, una tecnica, una corrente, un marchio di qualità?
È un formato di pubblicazione, che ha rappresentato in un certo momento una forma di riscatto e nobilitazione per il mondo del fumetto: è servito per passare dall’universo del comic book, cioè dell’albo, a quello delle librerie. Serve per poter dire “anche il fumetto ha i suoi romanzi”. In questo senso va bene che ci sia, perché poi è di questo che si parla nelle riviste generiche, in televisione: attraverso questa parola passa l’idea che il fumetto possa essere una cosa colta come il romanzo, anche se poi con questo termine sono state pubblicate anche delle ciofeche pazzesche. Mentre invece Fuochi, che è dell’84, non è nato come graphic novel, parola che non si conosceva in Europa e anche in America era poco usata, ma è comunque un prodotto più interessante della maggior parte dei romanzi che si sono pubblicati in Italia in quegli anni.
---------------------------------
Fabio Sera, 7 giugno 2010



